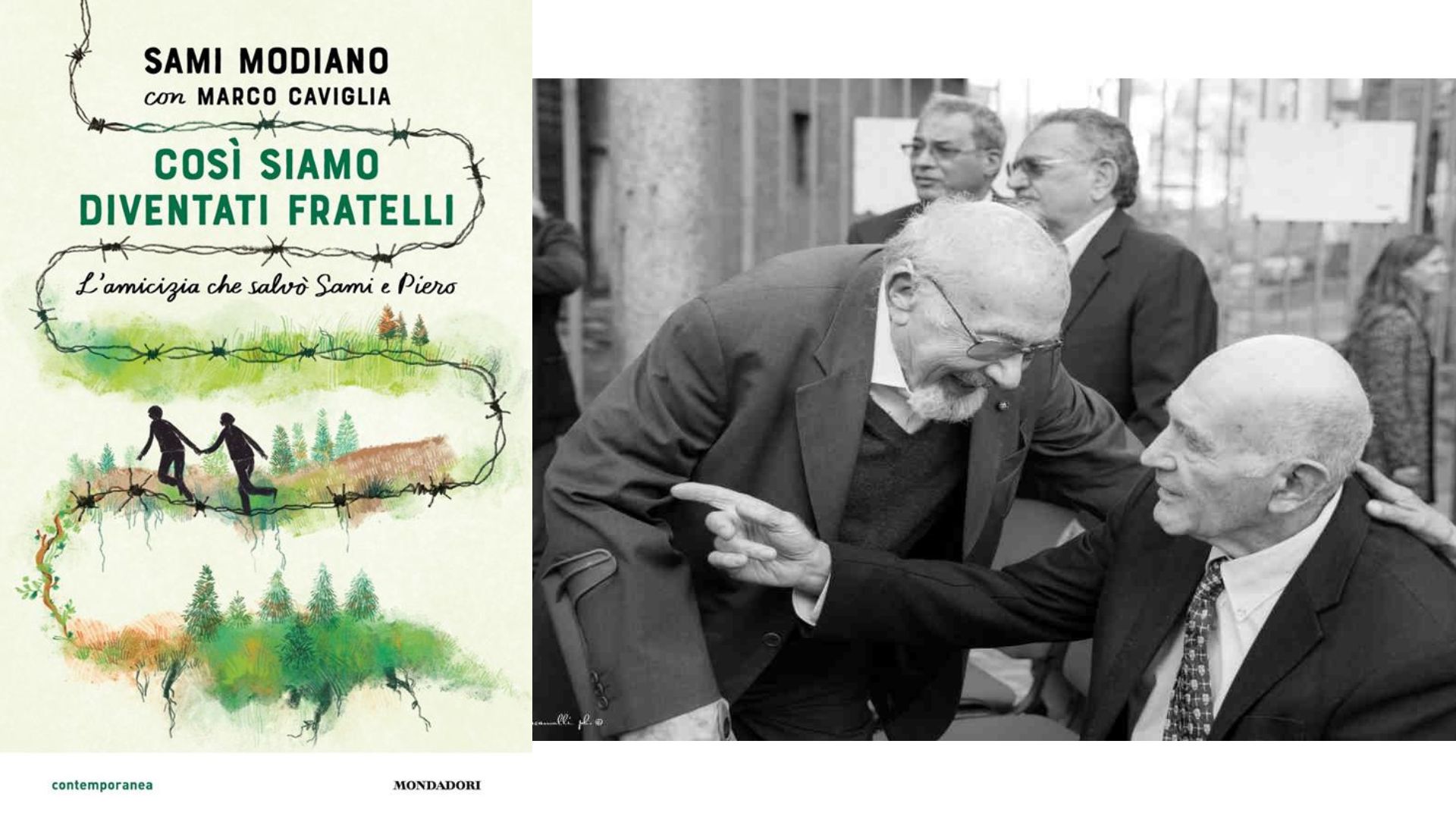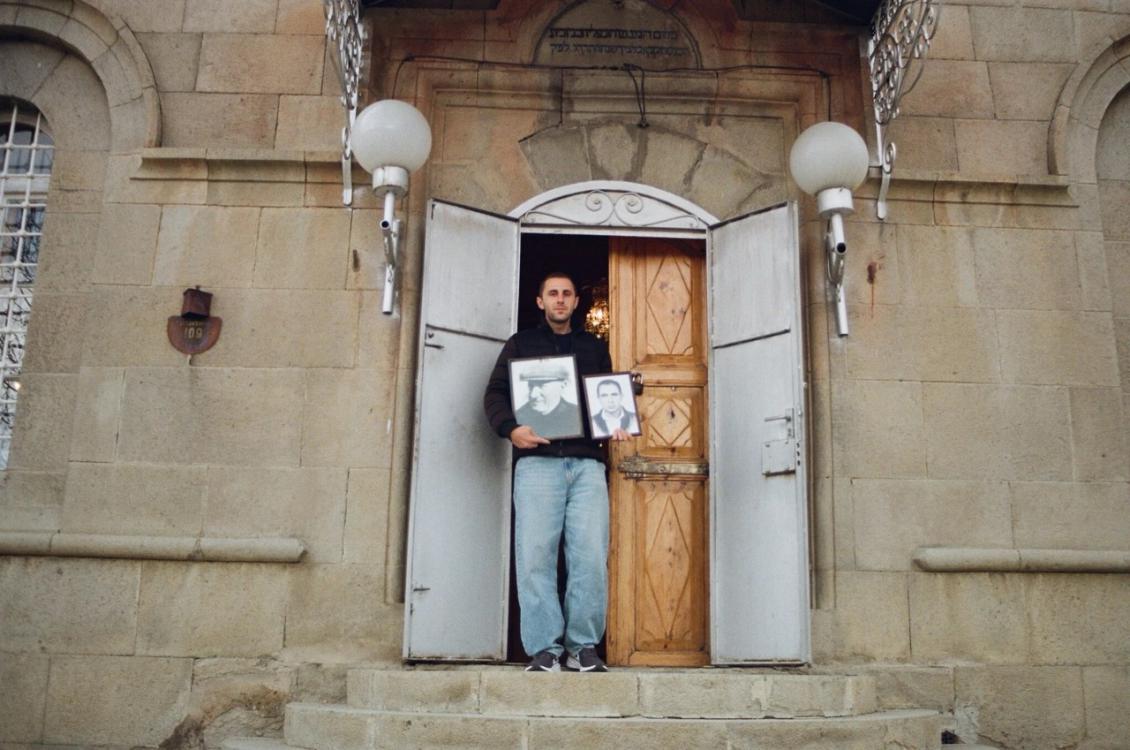I viaggi della memoria non sono mai solo un ritorno al passato. Sono piuttosto un ponte, un esercizio di confronto tra la storia e il presente. Camminare lungo i binari che portano al cuore di Birkenau significa non solo osservare ciò che resta della Shoah, ma interrogarsi su cosa significhi ricordare in un mondo che, troppo spesso, sembra smarrire le lezioni più fondamentali.
Ho avuto il privilegio di partecipare a questi viaggi in diverse fasi della mia vita. Da giovane, furono un’esperienza devastante ma necessaria, un’immersione nella consapevolezza che l’orrore non è mai qualcosa di astratto, ma l’effetto di scelte precise, di silenzi, di complicità. Più tardi, da presidente dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, ho capito quanto fosse cruciale trasformare quell’impatto personale in un percorso collettivo, offrendo ad altri giovani gli strumenti per riflettere e, soprattutto, per agire.
Eppure, con il passare del tempo e dei ruoli, ho anche iniziato a osservare con maggiore criticità il contesto in cui questi viaggi si inseriscono. Se da un lato rappresentano un’opportunità straordinaria per mettere studenti e cittadini di fronte alla realtà della Shoah, dall’altro rischiano, in alcuni casi, di diventare un gesto ritualizzato, una tappa obbligata priva di un’elaborazione profonda e duratura. Non è sufficiente visitare Auschwitz per comprendere davvero la Shoah. Serve un lavoro di preparazione, di confronto, di interiorizzazione che spesso viene trascurato.
Questo stesso rischio riguarda anche il 27 gennaio, il Giorno della Memoria. Nato con l’intento di rendere universale il ricordo della Shoah, il 27 gennaio ha certamente un valore simbolico enorme. Ma la sua istituzionalizzazione, spesso, lo confina in una giornata sterile, fatta di eventi formali, discorsi vuoti, progetti che si esauriscono nello spazio di poche ore. Il risultato è un “memorialismo” che rischia di anestetizzare il dolore e il significato profondo della Shoah, trasformandolo in una ricorrenza tra le tante, invece che in un impegno costante.
La memoria, per essere viva, deve essere scomoda. Deve interrogare le coscienze, spingere a fare domande difficili, anche su noi stessi e sulla società in cui viviamo. I viaggi della memoria, in questo senso, sono una delle poche esperienze che riescono ancora a scuotere nel profondo. Non basta leggere un libro o vedere un documentario: camminare nei luoghi in cui tutto è accaduto, respirare quell’aria gelida, posare lo sguardo sui resti di un’umanità distrutta è un’esperienza che non lascia scampo. Ma non deve finire lì.
Quello che manca, spesso, è il “dopo”. Cosa resta agli studenti che tornano da Auschwitz? Quanto viene davvero trasformato il loro sguardo sul presente? Troppo spesso, il ritorno alla quotidianità è accompagnato da un vuoto narrativo, da una mancanza di strumenti per tradurre quell’esperienza in azione. La memoria non può essere un atto passivo, né può essere confinata in un viaggio o in una giornata. Deve essere il punto di partenza per costruire una società più consapevole, capace di riconoscere i segnali dell’odio e dell’intolleranza nel momento in cui si manifestano, non quando è troppo tardi.
In un mondo in cui l’antisemitismo sta risorgendo sotto nuove forme, in cui il negazionismo trova spazio tra le pieghe dei social media e del populismo, il rischio è che la memoria diventi un guscio vuoto. I viaggi rappresentano ancora una possibilità concreta per combattere questo rischio, ma solo se accompagnati da una riflessione profonda e da un impegno quotidiano che superi le ritualità del 27 gennaio.
Non si tratta di fare “più memoria”, ma di farla meglio: non come celebrazione, ma come atto politico e morale. La memoria è uno strumento potente, ma solo se usata con coraggio e senza compromessi. I viaggi della memoria, se intesi in questo senso, possono davvero essere una chiave per costruire un futuro migliore. Ma dobbiamo essere disposti a cambiare il nostro modo di ricordare, rinunciando alla comodità delle ricorrenze e abbracciando la responsabilità dell’azione.