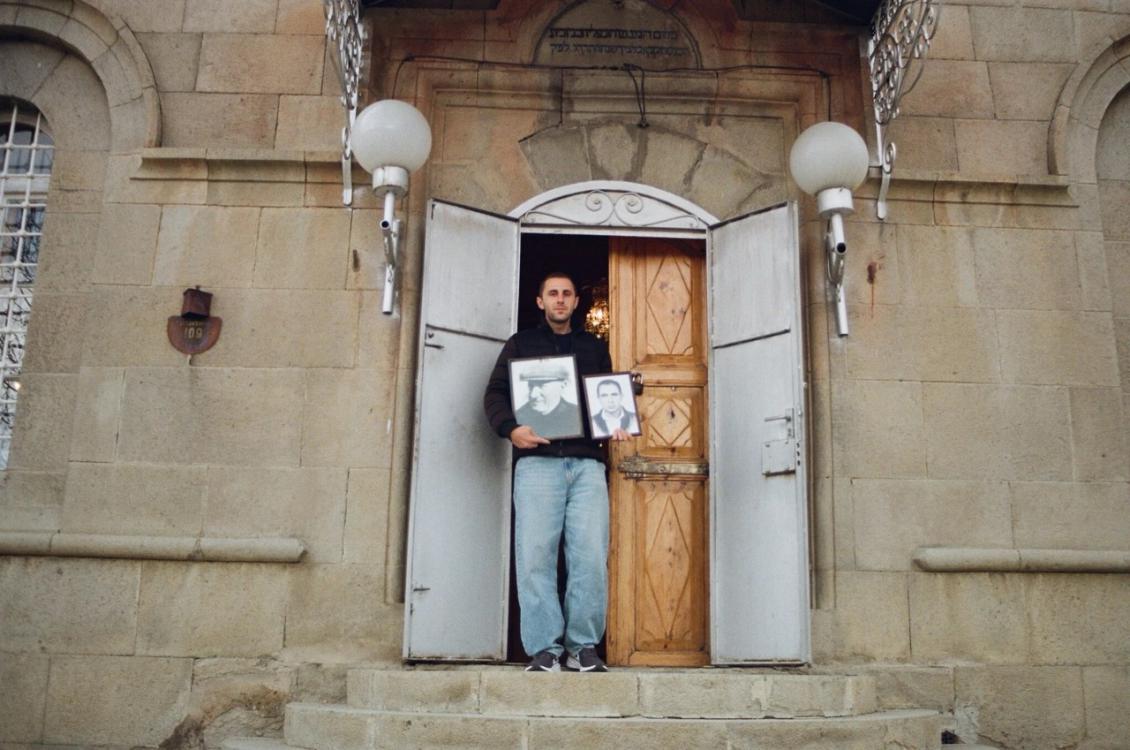Un paese senza governo stabile da quattro anni
Chi ama Israele e ammira le sue realizzazioni scientifiche, artistiche, tecnologiche ed economiche e rispetta la libertà e la democrazia pienamente realizzata nonostante il terrorismo e le guerre subite ininterrottamente dalla fondazione dello Stato, non può non essere preoccupato per il funzionamento di un sistema politico che da quattro anni non riesce a produrre un governo stabile ed ha chiamato il paese a ben cinque elezioni politiche generali. Il paese è andato avanti anche in questi anni, è cresciuto economicamente, ha resistito bene al Covid e all’aggressione iraniana. Ma certamente la mancanza di un governo stabile ha un costo notevole. Vale la pena di riflettere sulle cause di questo scacco.
Non è una novità assoluta
In realtà non si tratta di una novità. Quelli che siamo abituati a pensare come padri dello stato (Ben Gurion, Weizmann, Jabotinski, Dayan, Golda Meir) raramente sono stati d’accordo e talvolta, chi più chi meno, si sono combattuti molto duramente. Per citare solo un dato, Ben Gurion fra il ‘48 e il ‘63 ha costituito e guidato ben nove governi diversi, essendo costretto anche a un periodo di ritiro di due anni (‘54-’55); negli ultimi anni della sua vita si trovò in minoranza, uscì dal suo partito, ne fondò un altro e lo fuse in un terzo. Insomma allora, come tante volte in seguito, la politica israeliana fu confusa, accidentata e spesso ingrata nei confronti dei suoi leader.
La cause remote: la molteplicità
Le ragioni di questa conflittualità sono culturali. Dal tempo del Talmud la cultura ebraica è cresciuta su discussioni anche durissime; la religione non ha un’autorità centrale da quando i romani proibirono il sinedrio, anche i più grandi maestri, come Maimonide e Rashì sono stati contestati e discussi spesso e volentieri; le tradizioni locali si sono differenziate dappertutto e per esempio nelle nostre città, finché i numeri lo consentono, si sono sviluppate scuole “tedesche”, “spagnole”, “libiche”, ecc. oltre che “italiane”, ben gelose delle loro tradizioni. Questa molteplicità si ritrova nella composizione della popolazione israeliana, non solo sul piano religioso, ma anche su quello politico e sociale. Vi sono certamente più lingue e cucine diverse a Tel Aviv che a Roma o a Parigi. Alle differenze ebraiche poi si aggiungono le minoranze; arabi stanziali delle diverse tribù e beduini divisi in clan, drusi, cristiani di diversa confessione, minoranze più esotiche come i circassi o gli armeni. E questo ha prodotto altrettante richieste di rappresentanza politica. Fin da prima della fondazione dello Stato, il principio unificante del bipartitismo maggioritario che regna nella tradizione anglosassone è apparso inapplicabile. Il sistema elettorale israeliano è conseguentemente un proporzionale puro, con una soglia di ingresso al 3,5 per cento che per circa 4 milioni di votanti (su 6 aventi diritto) fa circa 130 mila voti e 4 deputati.
Le cause remote: la personalizzazione
Bisogna aggiungere che la cultura israeliana è certamente solidaristica, ha inventato la sola forma di socialismo pratico funzionante, il kibbutz; ma è anche molto individualistica e da sempre orientata sulla personalità dei leader. Questa personalizzazione spinta moltiplica i partiti. Alla Knesset oggi ne sono rappresentati 13 (di cui diversi sono in realtà federazioni di partiti) e molti altri se ne presentano alle elezioni. Il risultato è una frammentazione spinta; nel 2021 il primo partito (il Likud di Netanyahu) aveva 30 deputati su 120; il secondo partito (Yesh Atid di Lapid) 17; tutti gli altri ne avevano meno di 10 e di essi sette avevano ottenuto il 5 per cento dei voti (250.000 circa) o meno. Di qui anche una corsa ad alleanze e fusioni fra coloro che rischiano di non passare la soglia e la continua invenzione di nuovi partiti proposti da aspiranti nuovi leader.
La molteplicità dei temi
In paesi come l’Italia, la Francia o l’Inghilterra, la divisione politica segue una linea principale che contrappone “destra” e “sinistra” sui vari aspetti della vita sociale. In Israele le linee di divisioni sono di più e si incrociano: c’è la destra e la sinistra (soprattutto divisi per quel che riguarda i rapporti con i palestinesi), ma ci sono anche gli ebrei e gli arabi, i religiosi e i laicisti, i liberali e gli interventisti in economia. Queste molteplici divisioni rendono più difficile costituire maggioranze omogenee, fino al paradosso dell’ultima coalizione, divisa su tutto e ben presto caduta per tale ragione.
La causa prossima: “Chiunque ma non Bibi”
L’ultima divisione che si è aggiunta alle altre da qualche anno, è la più influente, separando i nemici di Netanyahu da quelli che sono disposti a collaborare con lui. Anche frammenti decisivi della destra ebraica e liberista (che è maggioranza nel paese) hanno deciso di sacrificare le preferenze ideologiche del loro elettorato, pur di liberarsi di Netanyahu. La ragione avanzata per questo ostracismo sono le accuse (una di corruzione e due di “abuso di fiducia”) contro cui Netanyahu si sta difendendo. Ma anche se il suo processo è ancora aperto, le accuse hanno mostrato molte debolezze giuridiche e di fatto e lo stesso Procuratore Generale ha stabilito che Netanyahu fino alla sentenza aveva diritto di continuare a fare il Primo Ministro e di candidarsi alle elezioni, l’opposizione alla sua leadership da parte di leader come Bennett, Sa’ar, Gantz, Liberman, che pure gli sono vicini ideologicamente, non è diminuita. Il processo è un pretesto, è chiaro che neppure una sua piena assoluzione basterebbe a ricucire la maggioranza di centrodestra. Che si tratti di invidia, di volontà di “uccidere il padre”, di vendetta per gli sgarbi o di genuina preoccupazione per il peso di una singola personalità nella democrazia israeliana, non si può dire. Certamente la causa più vicina e determinante dell’instabilità politica israeliana sta in questa scissione del centrodestra. Innaturale ma ormai irrimediabile. La sfida delle prossime elezioni è riuscire a sciogliere questo nodo.