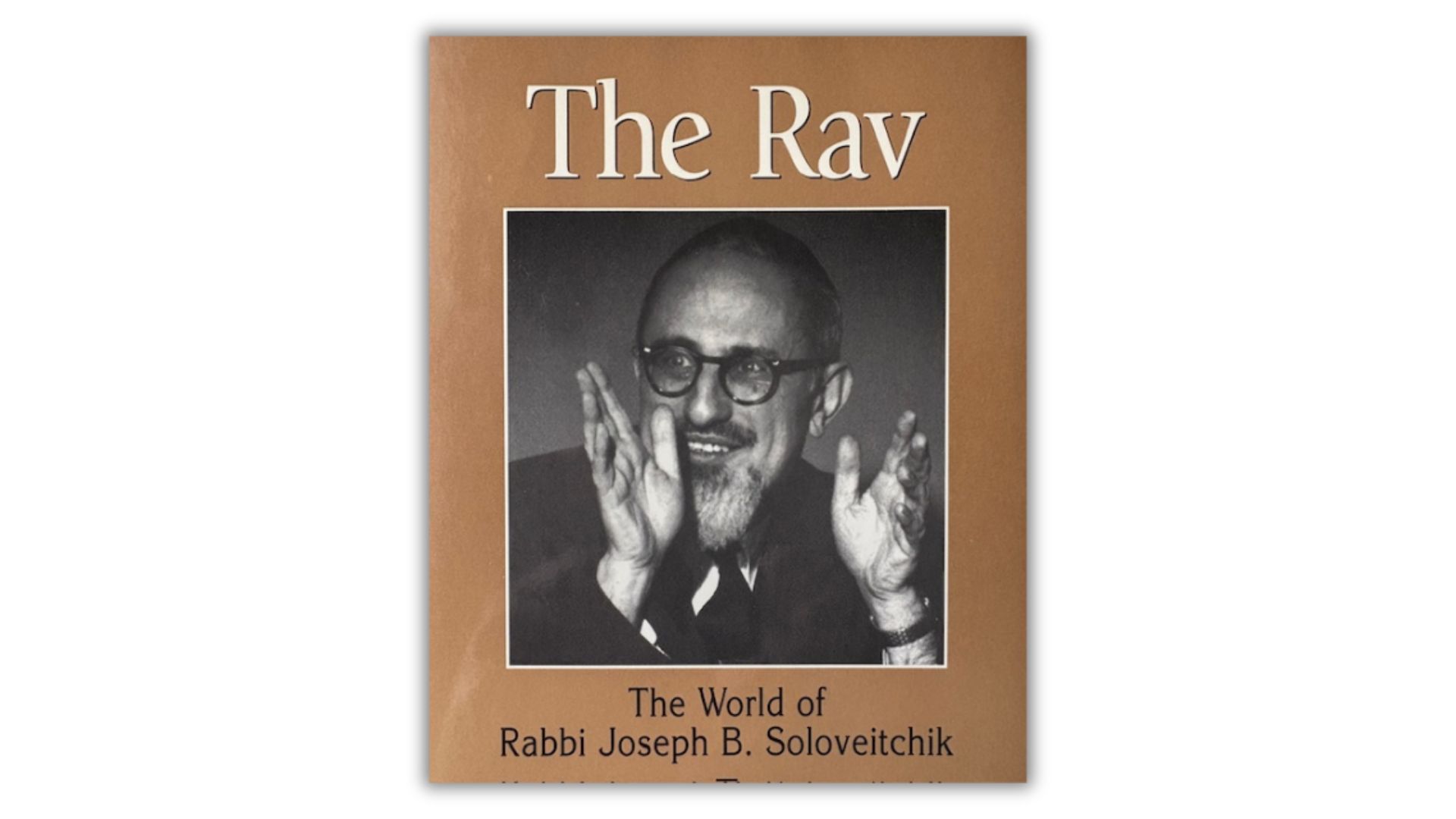Dei 1022
ebrei rastrellati il 16 ottobre 1943 e deportati nei campi di sterminio, solo
in 16 fecero ritorno a casa; tra questi Settimia Spizzichino fu l’unica donna. Shalom, negli anni, attraverso
interviste e articoli, ha raccolto le testimonianze di chi riuscì a fare
ritorno e di chi in qualche modo riuscì a fuggire o a nascondersi in quelle
terribili ore, evitando così la deportazione. Proponiamo nuovamente alcune di
queste storie tratte dal nostro archivio.
Shalom
settembre 1983 pag 22-23
Tante storie della nostra storia
Quaranta anni dopo la razzia nel Ghetto di Roma, la
deportazione degli ebrei romani attraverso testimonianze dirette
LE STORIE
Fernando Di Porto: «mi salvò la febbre»
In quell’ottobre
del ’43 avevo 5 anni. La notte tra il 15 e il 16 avevo la febbre, non riuscivo
a dormire; perciò mi alzai prestissimo e andai alla finestra. E là vidi (in via
Marmorata, dove abita-vamo) tre camion fermi, e una lunga fila di gente che
veniva spinta sui camion da soldati tedeschi armati di fucile. Era gente che
conoscevo: tra di essi c’erano mia zia e i miei cugini. Spaventato tanto da
dimenticare il castigo che mi aspettava per essermi alzato con la febbre,
chiamai mia madre: « Mamma, corri, stanno portando via zia Elvira e i suoi
figli!». Mia madre accorse, sbiancò in viso, chiamò mio padre. Mi avvolsero in
una coperta, e, insieme ai miei fratelli (eravamo in 9, dai 3 ai 13 anni, e mia
madre aspettava il decimo) fuggimmo sulla terrazza; ma anche lì non eravamo al
sicuro, ci avvisò la portiera, e allora andammo su un’altra terrazza, quella di
una palazzina dove non abitavano ebrei e poi ci rifugiammo in una segheria.
Dieci minuti dopo, i tedeschi irrompevano nel nostro appartamento, trovandolo
vuoto.
Lello Dell’Ariccia: «mia nonna e la nipotina»
Io con la
mia famiglia ero già nascosto da tempo in campagna. Mio zio Amedeo Tagliacozzo,
proprietario di una sartoria che riforniva il personale di varie ambasciate e
di alcuni era diventato amico, era stato avvisato da un funzionario
dell’ambasciata sovietica, prima del giugno 1941 (prima cioè della guerra con
l’URSS, n.d.r.) del pericolo che correvano gli ebrei. Così mio zio fece in modo
che tutta la sua famiglia e quella della sorella (mia madre) e del fratello,
trovassero tempestivamente un nascondiglio sicuro. Lui stesso però non volle
allontanarsi da Roma perché mia nonna, cioè sua madre, che aveva perduto pochi
mesi prima un altro figlio in un incidente stradale, non voleva allontanarsi da
casa dove erano custoditi tutti i suoi ricordi. Per caso la notte del 15 ottobre
era andata a dormire da loro un’altra nipotina, Ada, una bambina di sette anni.
La mattina del 16 mia madre decise di venire in città a portare uova e latte a
mia nonna, visto che a Roma c’era poco da mangiare. Partimmo molto presto e
arrivammo a Roma verso le 6 di mattina. Era passata solo mezz’ora da quando i
camion tedeschi avevano portato via quelli che erano rimasti a casa: la nonna
di 75 anni, mio zio e la piccola Ada. Tornati per strada fummo avvicinati da
alcuni commercianti della zona che conoscevano la nostra famiglia da trent’anni:
ci fecero andare a casa loro e ci tennero nascosti per un po’. Più tardi
tornammo in campagna. Qualche tempo dopo ricevemmo, giunto per vie tortuose, un
biglietto che mio zio aveva fatto cadere dal treno della deportazione. Dopo la
guerra abbiamo saputo che mio zio era riuscito a sopravvivere qualche tempo
prima di morire, sembra, a Dachau. Mia nonna e la mia cuginetta furono invece
uccise subito appena arrivate ad Auschwitz.
Graziella Limentani: «lo hanno preso col
carrettino»
Il 16 ottobre
avevo 22 anni, abitavo in via Luciano Manara, avevo una figlia di tre anni e
mezzo e aspettavo il secondo figlio. Andai a cercare mia madre in Piazza, la
chiamai sotto casa, ma i vicini mi vennero a dire di andare via, non c’era più
niente da fare, li avevano portati via tutti: mia madre Laurina, mio padre, mio
fratello con la moglie e due figli, mia sorella con sei figli. Scappai per via
Arenula e vidi i camion dei tedeschi che portavano via famiglie intere. Mi
rifugiai a Primavalle, dove si trovava già mio marito che era scappato prima,
quando si pensava che i tedeschi avrebbero preso solo gli uomini. E a
Primavalle sono rimasta nove mesi, poi mio marito è rientrato a Roma perché
erano rimasti pochi soldi. I tedeschi lo hanno preso insieme al carrettino
vicino alle Mura del Vaticano. Era il 18 aprile, quaranta giorni prima
dell’arrivo degli americani. Non è tornato più.
Angela Spizzichino Di Consiglio: «scappate
subito in chiesa»
La sera del
15 ottobre stavo da mia cognata in Piazza. Ero andata a trovarla e ad un certo
punto dissi: «Ho un brutto presentimento, mi pare di avere i tedeschi dietro le
spalle, andiamo via di qui, attraversiamo presto Ponte Garibaldi». Dopo dieci
minuti che con mio marito eravamo arrivati a casa abbiamo sentito le bombe.
«Vedi che avevo ragione», gli ho detto. Poi abbiamo continuato a sentire bombe
a mano per tutta la notte. La mattina del 16 sono uscita di casa con tre
bambini: la mia di nove mesi e due nipotine. Era venuta una mia sorella ad
avvertirci di scappare: era uscita presto per andare a fare la fila per le
sigarette e aveva visto i camion con i tedeschi, così era corsa in giro a dare
l’allarme a tutti quelli che conosceva. Io andai a finire per via Arenula che
era piena di tedeschi, così dissi alle mie nipotine: «Voi andate avanti, io
vengo appresso con la bambina. Se mi dovessero prendere, non piangete ma andate
subito in chiesa, se no prendono pure voi». Così attraversai S. Carlo e
svicolai in una stradina riuscendo a mettermi in salvo. Dopo ho girato tanto,
sono stata nascosta in tante case. Mio marito, che si era nascosto sul tetto,
si è salvato pure lui, ma dopo il 16 Ottobre i tedeschi gli hanno portato via
quattro fratelli.
Rina Pavoncello «Capinera»: «tra i
tedeschi con il libro di preghiera»
Abitavo a
S. Ambrogio e fin dalla sera del 15 ottobre cominciammo a sentire le bombe e ci
chiedevamo che cosa sarebbe successo. La mattina presto del 16 venne mia cugina
Rina e dalla strada ci gridò di far scappare gli uomini perché i tedeschi li prendevano.
Mia madre chiamò mio padre e mio zio che abitava lì vicino con tre figli maschi
per farli scappare. Poi però hanno incominciato a dire che prendevano anche le
donne e i bambini, così mia madre, Laurina, che aveva una gamba ingessata,
prese dei pacchetti di sigarette e incominciò a darli ai soldati per strada.
Erano soldati austriaci, non tedeschi. Gli fece cenno che doveva andare
all’ospedale e intanto spingeva avanti noi ragazzini. Quelli dissero «ya ya» e
noi, lesti lesti, riuscimmo a svicolare e con noi vennero subito altri ragazzi
che facevano finta di sorreggere mia madre per aiutarla a camminare. Ma lei fu
così svelta che riuscì pure ad acchiappare qualcuno già pronto a salire sul
camion e a farlo scivolare via, mentre i soldati erano distratti, un po’ dal
trambusto e un po’ dalle sigarette. Scappammo per via Monte della Farina. Qui
incontrammo un vecchio che ci disse di non passare di là ma di fare un’altra
strada: aveva capito che eravamo ebrei. Ci nascondemmo in una casa di piazza
Sonnino e ricordo che dalla finestra vidi passare la madre di «Piccola»,
l’orefice che sta a Piazza del Monte. Era la signora Teresa, moglie del rabbino
Amadio Fatucci. Io avevo dodici anni e quella scena non la scorderò più. Con
lei c’era qualcun altro, un figlio o un nipote. Due tedeschi davanti e due
dietro con il fucile puntato e lei in mezzo che camminava leggendo un libro di
preghiera.
Lionello Terracina: «vestitevi come se fosse
un giorno di festa»
Quella
mattina mi vennero ad avvertire di scappare perché portavano via gli uomini. Io
però mi affacciai alla finestra e mi accorsi che portavano via le famiglie
intere. Dissi ai miei: «Cambiatevi, vestitevi come se fosse un giorno di festa»
e li feci uscire a due per volta. Avevo 19 anni e oltre a mio padre e a mia
madre avevo un fratello e sei sorelle. Non abitavamo tutti insieme, così nella
confusione del momento ci scordammo di avvertire mia sorella che fu portata via
con il marito e due figlie. Noi andammo a casa della suocera di mio fratello,
ma io dissi che probabilmente i tedeschi sarebbero venuti pure li. Infatti
avemmo appena il tempo di prendere un caffè e di uscire che, svoltato l’angolo,
arrivò un camion di tedeschi che caricò tutti quelli che erano rimasti a casa.
Andammo a San Lorenzo, nascosti in una stanzetta e un giorno mio fratello vide
dalla finestrella una persona di nostra conoscenza che diceva a dei soldati
tedeschi: «Venite, venite, vi porto io dove stanno nascosti». Per fortuna non
ci trovarono. Un giorno siamo stati nascosti anche dietro la sala operatoria
dell’ospedale S. Spirito. Tornammo a casa nostra, ma era cominciata la caccia
all’ebreo e un sergente della Croce Rossa che conoscevamo ci portò a casa sua,
un villino disabitato dove faceva anche da guardiano. Lì passammo parecchi
mesi. Ricordo che all’ora del pranzo ci portava la sua gavetta piena di riso e
indivia. Era il suo pasto e lui lo portava a noi. Nel frattempo la
nostra famiglia era stata decimata. I tedeschi avevano preso due fratelli e una
sorella di mia madre con tutta la famiglia e mia sorella con quattro figli e il
marito.
Angelo Di Veroli: «i tedeschi sono alti come
i cancelli del Tempio»
Avevo una
trentina d’anni allora. Quel giorno scappai di casa con mio figlio piccolo che
tenevo per mano, lasciando mia moglie perché pensavo che avrebbero preso solo
gli uomini. Ricordo che mia suocera diceva: «Sbrigati, sbrigati, ci sono i
tedeschi… sono tanto alti che arrivano ai cancelli del Tempio». Tanto era il
terrore che lei li vedeva altissimi. Mi rifugiai in un vicolo e da lì a Piazza
Venezia dove presi un autobus che mi portò alla stazione a casa di amici che ci
nascosero.
Sergio Terracina: «bloccò la porta con una
lastra di marmo»
Mia madre,
che abitava con mia sorella Vanda in via Goffredo Mameli, stava scendendo le
scale per andare a mettersi in salvo a casa di amici cattolici, quando vide
entrare nel portone un gruppo di soldati tedeschi con un interprete, attraverso
il quale domandarono alla portiera informazioni sulle famiglie ebree che
vivevano là. La portiera, vedendo le due donne che scendevano le scale (mia
sorella allora aveva 15 anni) disse ai tedeschi: «Su, su, salite», facendo
contemporaneamente cenno a loro due di uscire e di scappare. Un’altra mia
sorella, Emma, bloccò invece la porta di casa sua con la lastra di marmo che
stava sopra il comò. I tedeschi bussarono, poi cercarono di aprire, ma la porta
bloccata faceva resistenza e dopo un po’ convinti che a casa non ci fosse
nessuno, rinunciarono e se ne andarono. Così si salvò lei, il marito e un
figlio.
Shalom
settembre 1983 pag. 23-24
Quel ponte di Auschwitz
Settimia Spizzichino: l’unica donna sopravvissuta tra
i deportati del 16 ottobre
Quel 16 ottobre
avevo 19 anni e vivevo in via della Reginella insieme a mio padre, mia madre,
altre due sorelle e una nipotina. Dopo la consegna dell’oro, pensavamo che i
tedeschi ci avrebbero lasciato in pace, invece la mattina presto di quel sabato
sentimmo dei rumori per la strada. A noi quella mattina non ci avvertì nessuno
e ci presero tutti, tranne mio padre che riuscì a svicolare e a fuggire. Io
ricordo che allora tentai di ribellarmi. Volevo reagire, scappare, ma i miei in
buona fede mi dicevano «Vedrai, che ci possono mai fare». Eravamo sui carri
bestiame diretti ad Auschwitz e mia madre ancora mi diceva «Che vuoi che ci faranno, mica ci ammazzeranno,
lavoreremo». Poi ci furono i vagoni
piombati, l’arrivo in Germania, Auschwitz, la selezione… Feci la trafila che
i tedeschi facevano passare a tutti coloro che arrivavano nel campo. Quelli che
erano partiti con me da Roma, a parte quelli spediti ai campi di lavoro, erano
stati eliminati tutti subito. La neve che abbiamo trovato all’arrivo, i lavori
pesanti e la cattiva alimentazione, tutto ha contribuito alla decimazione. In
mezzo a questa situazione drammatica, la «fortuna» ha voluto che fossi messa in
un blocco di esperimenti, ero insomma salva dai lavori pesanti e dagli appelli.
Fui sottoposta ad esperimenti e poi in qualche modo mi fu evitato il peggio grazie
ad una infermiera, che poi depose anche al processo di Norimberga. Quando i
russi sono stati vicini, i tedeschi ci hanno portato dalla Polonia in Germania,
a Bergen-Belsen. Si era in piena disfatta tedesca ed era ancora peggio perché
loro si accanivano ancora di più su noi prigionieri, non volevano lasciare
prove di quello che avevano fatto. Poi gli americani arrivarono ad Hannover che
era relativamente vicino, solo che loro non sapevano che c’era un campo di
concentramento. Bergen-Belsen era in una foresta lontano dal centro abitato e
fummo noi dopo aver visto i tedeschi che scappavano, ad andare incontro agli
americani. A quel punto io stavo malissimo avevo 21 anni e pesavo 30 chili. Ho
vissuto per due anni in campo di concentramento e credo che quello che mi ha
dato maggiormente la forza di resistere, quello che proprio mi ha tenuto
attaccata alla vita è stato il pensiero che dovevo tornare per raccontare. Non
doveva finire così, ci dovevano essere testimoni che avrebbero raccontato tutto
quell’orrore, «lo devo sopravvivere mi dicevo, non so né come né quando ma devo
tornare a Roma». Ricordo che c’erano anche tanti bambini quando stavo nel
blocco degli esperimenti, li ho rivisti dopo tanti anni in occasione di una
commemorazione, ormai erano uomini, alcuni con famiglia. Ricordo anche di aver
visto quella che chiamavano «La casa delle bambole», dove portavano le donne
più giovani a far da prostitute per i soldati. Noi andavamo in un bosco a
raccogliere erbe medicinali ed uscendo dal campo vedevamo questa costruzione in
un angolo. Era l’ultima tappa sia per quelle donne che per i soldati che poi
erano quelli che andavano sul confine russo, in prima linea. Ad Auschwitz ho
conosciuto un ragazzo tedesco ebreo anche lui, ci vedevamo attraverso
l’Inferriata del blocco nel quale ero rinchiusa. Questo ragazzo amava tanto l’Italia
e con me parlava italiano perché voleva imparare bene la lingua. Diceva sempre
che finita la guerra voleva venire in Italia perché dovevamo proseguire questa
amicizia. Ricordo che verso la fine mi disse «Nel caos della liberazione chissà
se ci incontreremo, diamoci appuntamento sul ponte di Auschwitz». Invece ci
trasferirono a Bergen-Belsen. lo non avevo l’indirizzo di questo ragazzo, non ci
eravamo potuti mai dare neanche la mano, tutto era sempre avvenuto attraverso
l’inferriata e poi non potevamo tenere foglietti, c’erano perquisizioni molto
severe, così ci conoscevamo solo di nome. Quando tornai a Roma e più tardi
ripresi a lavorare, un giorno tornando a casa una donnetta che stava sempre
seduta al portone mi disse che qualcuno mi aveva cercato. «Se mi cercano ancora
ditegli di venire a trovarmi dove lavoro» dissi io. Infatti venne a cercarmi ed
era proprio lui, il ragazzo del campo, Ci siamo baciati e abbracciati. «lo
sapevo che non eri morta, lo sentivo». Quando era stato liberato era venuto a
cercarmi, però lui mi chiamava Mimmi e non Mimma e così nessuno mi riconosceva
né in Comunità, né in Piazza. Poi lui era dovuto andare in America perché in
Italia gli scadeva il per messo di soggiorno, lì aveva conosciuto una brava
ragazza e si era sposato, anche il lavoro gli era andato bene, perché conosceva
tante lingue. Approfittando di un viaggio di lavoro in Inghilterra aveva deciso
di riprovare a cercarmi e infatti tanto ha girato che ci è riuscito. Voleva
aiutarmi ma io ormai non avevo bisogno di niente, lavoravo e avevo anche
ritrovato mio padre.
Shalom
novembre 2008 pag. XIV
La scomparsa di Leone Sabatello detto ‘Leoncino’
Deportato il 16 ottobre 1943 insieme ad altri 1000
ebrei romani, è stato uno dei 16 uomini ritornati da Auschwitz
“Leoncino”
se n’è andato come aveva vissuto tutta la sua vita dopo Auschwitz: in un
silenzio dignitoso ma carico di emozioni, di rabbia, di dolore, di speranze, di
storia e di memoria. Agli inizi degli anni ’90, quando iniziammo a raccogliere
i racconti dei sopravvissuti italiani alla Shoah, a testimoniare con coraggio e
passione la più enorme tragedia della deportazione degli ebrei dall’Italia, la
razzia del 16 ottobre a Roma, era una sola persona: Settimia Spizzichino. Nessuno
dei 16 uomini tornati parlava, come se inconsciamente avessero delegato alla
sola Settimia il doloroso compito di farlo. Nel 1995 Arminio Wachsberger, Lello
Di Segni e Sabatino Finzi accettarono, con molta fatica, di raccontare, e fu
proprio quest’ultimo che mi parlò di un suo caro amico, nato e cresciuto come
lui in Portico d’Ottavia: Leone Sabatello, per tutti “Leoncino”. Ci
volle un altro anno perché riuscisse a rompere il muro di silenzio che s’era
imposto da sempre di rispettare, quando una mattina di giugno del 1996 mi fece
entrare in casa sua. Mi trovai di fronte un uomo forte, tormentato e
diffidente, ma col quale riuscii da subito a stabilire un rapporto di amicizia
e di simpatia che sarebbe durato fino ad oggi. L’aspetto che più mi impressionò
di quel primo incontro fu la sua conoscenza della lingua tedesca: più passavano
le ore, più il suo tedesco diventava automatico e chiaro. L’aveva imparato in
campo, me lo confessò con orgoglio: “C’è stato delle volte che m’ero
dimenticato l’italiano, solo tedesco parlavo. Il tedesco lo dovevi afferà
subito, e io l’ho imparato per vivere. Me so’ fatto omo ‘n campo, co gente che
parlavano sei, sette lingue, e noi sapevamo dire soltanto Ja!”.
Era nato il
18 marzo del 1927 a Roma e la sua era una bella famiglia come tante in Piazza:
due fratelli maschi e cinque femmine. Erano stati tutti presi la mattina del 16
ottobre, con le due piccole figlie del fratello Rubino, la loro mamma, Enrica
Tagliacozzo, e uno zio paralitico. Solo Leoncino sarebbe ritornato, ma quelle
bambine non le avrebbe mai dimenticate: “… una tre anni e una qualche
mese. Una se chiamava Alba Celeste e una Liana. Erano bellissime”. Era
forte, nonostante i suoi quindici anni, quindi i nazisti sulla Judenrampe di
Birkenau lo selezionarono per l’impiego lavorativo col numero di matricola
158621: dopo un breve periodo di quarantena lo inviarono con l’amico Sabatino
Finzi ed altri ebrei romani nelle miniere di Jawischowitz, uno dei sottocampi
più terribili di Auschwitz. La descrizione che mi fece di questo campo rimane
una fonte storica dettagliata che rimarrà a disposizione degli studiosi negli
anni futuri. Ma era il suo modo di descrivere gli avvenimenti, cosi semplice ed
essenziale, ricco però di disincantata ironia, che riusciva a trasmettere il
senso di quella tragica realtà, come nel caso di una punizione che una volta fu
inflitta agli ebrei italiani imprigionati a Jawischowitz: “Era Natale del
1943. Uno de noi s’è messo a fà ‘n bisogno proprio sotto l’albero de Natale che
avevano fatto i tedeschi. J’hanno preso er numero e hanno detto: “Fuori
tutti gli italiani!”. C’hanno fatto uscì fori nudi come c’aveva fatto il
Padre eterno; faceva trenta gradi sotto zero, che, con rispetto parlando, quando
urinavo me se gelava l’urina, e co ‘a pompa c’hanno inaffiato. Per riscaldarci
s’appoggiavamo l’uno contro l’altro. Io si nun moro là nun moro più”. E
non gli mancava certo la sincerità, anche quando era scomoda da ammettere:
“Io ho sempre rubato. Rispettavo vari amici che si conoscevamo, ma
l’altri…morte sua vita mia. Ho rubato sempre, perché se no nun sarei
rivenuto”. Con l’evacuazione di Auschwitz, fu costretto ad effettuare la
marcia della morte e altri mesi di tormenti nel campo di Buchenwald, per essere
liberato alla fine di aprile del 1945 nei pressi di Berlino. Quando ritornò a
Roma, andò dritto al Tempio: ”A prima cosa che ho guardato è il Tempio, che me
credevo che nun esistesse più”. Non trovò più nessuno a casa ad
aspettarlo, ma il destino gli riservò l’unico dono che gli avrebbe permesso di
sopravvivere: una moglie affettuosa, intelligente ed estremamente sensibile. E
una suocera amorevole, che lo accolse come un figlio: “Io dopo so’ stato
fortunato in una cosa. Disgraziatamente avevo perso tutti i genitori, però ho
trovato la mamma… la mamma di mia moglie che m’ha fatto da madre. Quello
che mi ha fatto quella donna vun me ha fatto nessuno nella vita. M’aveva fatto
ricapire che cosa era ‘a famija. Se nun me fermava mi’ moje io c’avevo dodici
fiji.” In questi anni siamo sempre rimasti in contatto, ma l’estate appena
passata abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci a parlare ancora di Auschwitz
per ore, naturalmente spesso in tedesco. Abbiamo preso in giro i tedeschi e il
suo amico Sabatino che “se lamenta sempre, ma è forte come ‘n toro”;
abbiamo riso, scherzato, versato lacrime, ma questa volta il suo pensiero era
rivolto in modo ossessivo al ricordo delle sorelle uccise in Polonia. La rabbia
per la loro sorte era diventata un fuoco sempre più difficile da spegnere:
“Io speravo una cosa, che de cinque sorelle da vederne una. Nun c’ho avuta
‘sta soddisfazione. So’ morte tutte”. Mi confessò anche di essersi illuso
per anni di una loro assurda salvezza. “Lo sai che tante volte so’ stato
in Israele con la speranza de rincontrare le mi’ sorelle? Le cerco in mezzo a’
popolazione. Me dico: “Hai visto mai che in mezzo a ‘sta gente c’è mia
sorella?” Spero di vedere qualche volto che… è una cosa che c’ho dentro
ar cervello, ce l’ho sempre avuta. Ancora io nun l’accetto”. Ci siamo
ripromessi di incontrarci ancora, ma due mesi dopo l’ha colto una polmonite,
quella polmonite che l’aveva risparmiato a Jawischowitz. All’ospedale mi ha
fatto chiamare, l’ho visto per l’ultima volta. Vicino a lui c’era sua moglie,
anche lei ammalata, che però amorevolmente non l’ha abbandonato nemmeno per un
istante, e una delle sue figlie, le gioie della sua vita, strameritate. Mi ha
riconosciuto e mi ha sorriso, con tenerezza infinita. Il giorno del suo
funerale ero ad Auschwitz, l’ho ricordato proprio là, dove i nazisti gli
avevano strappato i suoi cari, la sua prima vita. Non riuscivo a dimenticare
una delle sue affermazioni che più mi avevano colpito: “Al Collegio
Militare abbiamo messo delle coperte che c’avevamo noi. Poi c’hanno chiesto
altro oro, e ce dicevano si qualcuno era di religione cattolica o volevamo
diventare cattolici. Qualcuno ha detto de sì, ma noi ce siamo raccolti tutti
quanti in famiglia e siamo rimasti quelli che siamo sempre”. Caro
Leoncino, se noi rimarremo “quelli che siamo sempre” sarà anche
grazie a te.
Marcello
Pezzetti
Shalom
giugno 2012, pag. 44
Addio Sabatino Finzi 158556
Si è spento a 85 anni uno degli ultimi sopravvissuti
alla deportazione nazista del 16 ottobre
Aveva 85
anni e gli ultimi anni, così come per altri ex deportati, li aveva passati a
raccontare e a testimoniare gli orrori della deportazione e dell’internamento
nel lager di Auschwitz. Sabatino Finzi era nato a Roma l’8 gennaio 1927,
arrestato e deportato ad Auschwitz all’età di 16 anni, era stato catturato
nella retata del 16 ottobre |943. Il ‘suo’ numero tatuato sul braccio era
158556. Fu l’unico minorenne che riuscì a tornare a Roma dei 1.022 deportati.
Come riuscì
a sopravvivere? Lo spiegò alcuni anni fa in una intervista: “Dovevo
sembrare più grande. Perché avevo visto che i bambini li ammazzavano tutti. Non
lavoravano, e alle SS non servivano. Li portavano fuori dai blocchi, e
ta-ta-ta. Li mitragliavano. lo ero già un giovanetto. Allora ho detto di avere
più anni, perché in quel modo potevo rendermi utile. Così sono so-pravissuto.
Ho sempre avuto un sesto senso”.
Recentemente
aveva confessato: “Sono andato a Gerusalemme, al Muro del pianto. E come
tutti ho infilato un bigliettino. Ci ho scritto sopra: ‘Hitler, non ce l’hai
fatta a farmi fuori. Sabatino Finzi è ancora qui, come mio figlio Giorgio e
come mio nipote”.
Shalom ottobre
2013, pag. 6
Quel giorno che ha cambiato la mia vita
Shalom ha intervistato Lello Di Segni, che insieme a
Enzo Camerino, è l’ultimo dei sopravissuti alla deportazione del 16 ottobre
1943
Lello Di
Segni, classe 1926, lo trovate ogni mattina seduto al tavolino del suo bar
preferito in via Catania. Nella zona, dove fino a pochi anni fa aveva una
piccola attività commerciale, lo conoscono tutti, anche se non tutti conoscono la
sua storia di deportato e di sopravvissuto allo stermino ebraico. “Ho
lavorato per un anno, dal 1943 al 1944, come uno schiavo a Varsavia dove
d’inverno la temperatura scendeva di molti gradi sotto lo zero”, ripete al
cronista di Shalom e all’esterrefatto giovane barista cinese. “La mia
sopravvivenza – spiega – forse è dipesa da due sole cose. Primo lavoravo,
lavoravo e lavoravo senza fare domande, senza pensare, eseguendo in modo
automatico e immediato gli ordini. Secondo, ogni giorno e ogni notte prima di
addormentarmi pregavo il Signore, con fede e speranza, con una preghiera che mi
aveva insegnato mia nonna”. Lello Di Segni aveva 16 anni quando fu
deportato con l’intera famiglia: il padre Cesare – unico altro sopravvissuto –
la madre Enrica Zarfati, due fratelli Angelo e Mario, una sorellina Graziella e
l’anziana nonna; nel giro di pochi minuti il loro mondo familiare e sociale – vivevano
nel cuore del quartiere ebraico, in via Portico d’Ottavia 9 – andò in pezzi.
“L’impatto – ricorda – fu terribile con comandi urlati in tedesco, una
lingua che non capivamo e che io ho imparato pochissimo in due anni di
prigionia”
Lello Di
Segni ha raccontato la sua storia in un libro “Buono sogno sia lo
mio”, a cura di Edoardo Gaj: “Ricordo come fosse ieri quella mattina
e quel tragitto breve eppure interminabile da casa fino a quei camion nazisti,
parcheggiati di fianco alla Sinagoga. Riesco ancora a vedere chiaramente le
facce tristi e compassionevoli di quei passanti non ebrei che avevano capito ma
che assistevano inermi, impotenti alla scena, senza poter intervenire”.
Quel giorno cambierà la vita di Lello che nell’arco dei due anni successivi conoscerà
luoghi mai immaginati (Auschwitz, Varsavia, Hallen, Bergen-Belsen, Dachau),
supererà esperienze terribili di botte, violenza, fame, sete, freddo, fatica e
di solitudine per l’incapacità di poter comunicare con gli altri prigionieri.
Per due anni non sarà più un essere umano, sarà un numero il 158526, sarà uno
stucke, un pezzo, che poteva sopravvivere solo se poteva lavorare senza sosta
(spostava sacchi del peso di cinquanta chili, quando lui ne pesava meno di
quaranta). “Eravamo come dei fantasmi, indifferenti a tutto e dimenticati
da tutto. L’odio verso gli ebrei era troppo forte. Il disprezzo e l’odio non
permettevano nessun gesto di pietà o compassione, nessuno”. Si poteva
essere uccisi per una minima man-canza. E Lello ricorda come gli vennero rubati
gli zoccoli da un prigioniero e di come a sua volta dovette rubarli ad un altro
per poter sopravvivere alle marce e alle lunghe ore di lavoro. E ricorda bene
anche la fame che lo spinse persino a rubare.
Una grave
denutrizione che poi avrebbe condizionato la sua esistenza anche negli anni
successivi, con diversi interventi allo stomaco. Il 10 giugno 1945 Lello
tornerà a Roma, dove alcuni mesi dopo ritroverà il padre, ritornato con i segni
di una malattia nei polmoni contratta nelle miniere tedesche. Padre e figlio
saranno uniti ancora di più dalla terribile comune esperienza della
deportazione e della Shoah e da una iniziale incapacità a parlarne. “I
primi tempi ho preferito tacere. Preferivo rimanere in silenzio: non avrei
sopportato lo scetticismo degli intervistatori, il fatto che qualcuno avrebbe
potuto interrompere i miei racconti accusandomi di esagerare alcuni particolari
della mia storia”. Poi con il trascorrere degli anni Lollo si è aperto al
racconto, all’incontro con tante scolaresche, alla testimonianza, e alle
interviste. Con una sola precauzione: non ha voluto ritornare più nei luoghi
della sua tragedia, non ha mai voluto partecipare ad un viaggio della memoria
nei campi di sterminio. “Non ce la faccio, è più forte di me, sono
sensazioni ed emozioni troppo intense, troppo dolore e io non sono più in grado
di reggere un peso simile. Non posso e non voglio”.
Giacomo
Kahn
Shalom.it 31-10-2021
Ritrovate dal CDEC
sei interviste del 1955 ai sopravvissuti del 16 ottobre 1943
Michelle Zarfati
Shalom.it 26-10-2018
Addio Lello Di Segni.
Era l’ultimo sopravvissuto alla retata del 16 ottobre
Giacomo Kahn
Shalom.it 16-04-2023
Gli ebrei italiani
sulle macerie del ghetto di Varsavia e della rivolta
Marcello Pezzetti