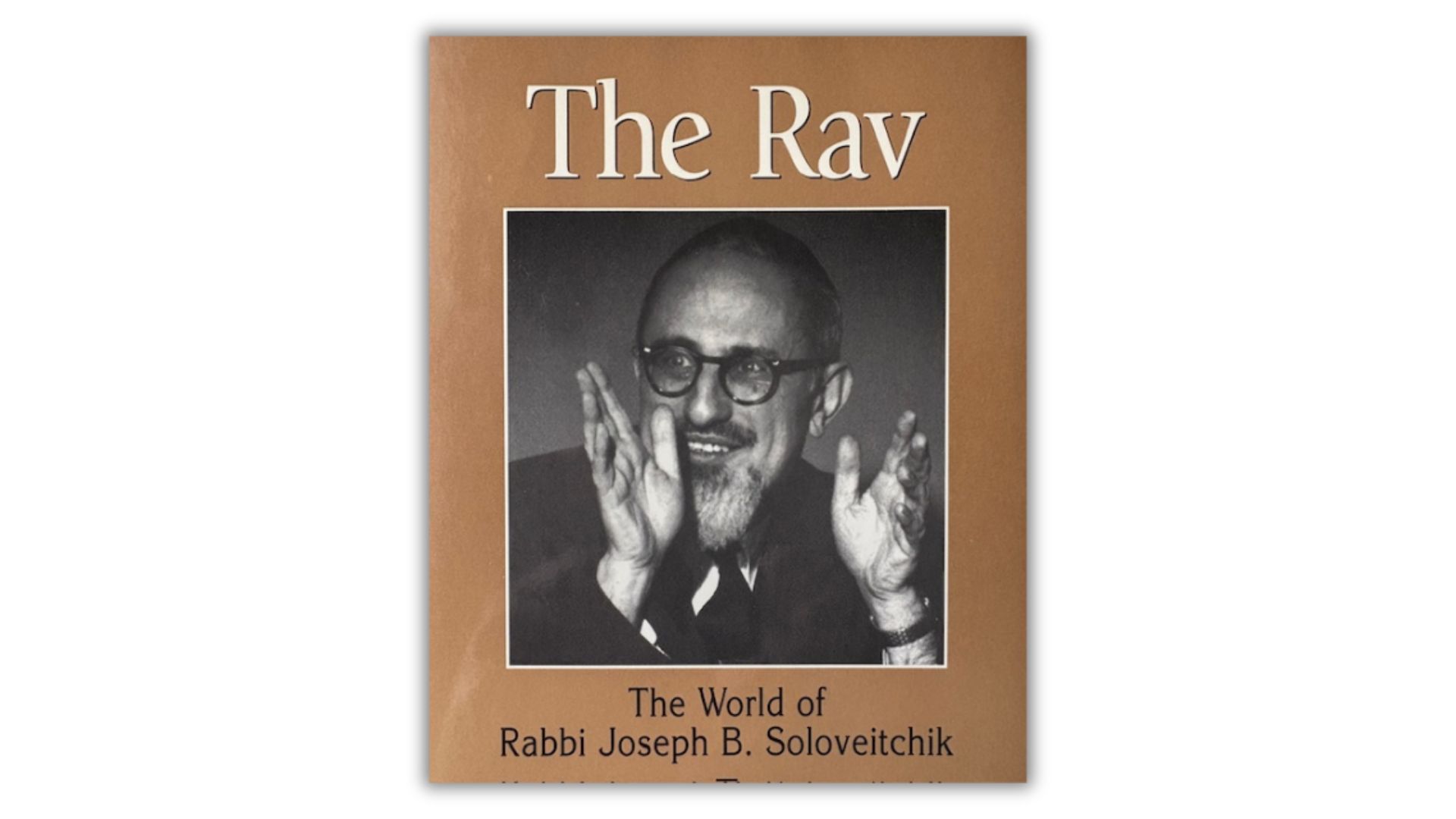Siamo alla vigilia di Rosh Hashanà e la mitzvà più importante che contraddistingue questa festa è lo shofar.
Questo suono antico che penetra nel cuore di chi lo ascolta ha molteplici significati.
A Roma per diversi decenni lo shofar veniva identificato con il Maestro Settimio Di Castro z.l.
Conosciuto anche come “Sisello” o “Fuji currenno” perché era la frase che ripeteva spesso alla moglie Giuseppina Fiano, da tutti conosciuta come Peppina, che chiamava affettuosamente “padrona” quando passeggiavano, o “il roscio” per il colore dei capelli o “capretta rossa” (ma questo in realtà era il soprannome del padre Giacomo) era il “toqea” ufficiale (colui che suona lo shofar) del tempio maggiore.
Il suo modo di suonare questo corno era unico e inconfondibile. Sembrava un suono che scendeva dal cielo, potente, lento, con i tre tipi di suono netti e distinti.
Aveva ereditato la tecnica dei toqeim romani che lo avevano preceduto, come Robbì Salomone Perugia o Giacomo Funaro, conosciuto come il “bechor”.
Quando scendeva dalla tevà la gente lo circondava per fargli i complimenti, ma lui rispondeva a tutti: “Troppi lavativi…” espressione che gli ebrei romani usano per dire che si sta esagerando.
Uno degli ultimi anni in cui suonò lo shofar, uno dei frequentatori gli andò incontro per congratularsi. Lui lo ringraziò e a bassa voce disse una frase che mi sconvolse: “Grazie… tra l’altro non sono io che suono lo shofar…”.
Ne compresi il senso molti anni dopo leggendo alcuni commenti dello Zohar (testo fondamentale cabalistico) e la cosa che mi sorprese di più era che lui era tutt’altro che un cabbalista!
Ma il brano che il toqea legge sottovoce, coperto completamente dal talled è cabbalà allo stato puro.
Molti credono che il suono dello shofar serva solo a risvegliare il sentimento di pentimento delle cattive azioni, ma i significati sono molto più profondi. Intanto colui che suona, recita una sua confessione personale dei peccati e afferma di essere consapevole di non essere degno di questo impegno e si chiede: “Come faccio a rappresentare tutta la collettività?”
Si chiede anche l’aiuto degli Angeli preposti a far uscire i suoni perfetti, in modo tale che le lettere che compongono il tetragramma del Nome Divino, si uniscano in maniera armoniosa, per far si che li Signore si alzi dal Trono del giudizio assoluto e si segga sul Trono della Misericordia per giudicare il popolo ebraico e l’umanità intera.
Per realizzare questa impresa titanica c’è bisogno dell’aiuto non solo delle Sfere Celesti, ma anche di tutti i presenti nel tempio, uomini, donne e bambini.
Il toqea prima di recitare la benedizione dice ad alta voce la formula: “Lazeth ulozzì” che significa “Per uscire e far uscire (d’obbligo)”. A questo punto il pubblico deve rispondere “amèn” alla benedizione, ascoltare in silenzio le prime trenta suonate e rimanere in silenzio senza parlare fino alla fine delle seconde trenta suonate durante la ripetizione dell’amidà.
La gente che al tempio chiacchiera prima della fine delle suonate indebolisce l’opera di chi suona.
Zio Settimio non era conosciuto solo per il suono dello shofar.
La tefillà di shachrith del giorno di Kippur era un altro suo gioiello: il viddui (confessione dei peccati) come lo recitava lui, coinvolgeva anche tutti coloro che non conoscevano l’ebraico. La sua kavvanà (concentrazione) con cui lo recitava era un qualcosa che andava a supplire la sua voce che non era certo da cantore, ma sembrava fosse in presa diretta con Kadosh Baruch Hù.
Era un purista del minhag (rito) e pretendeva dai suoi allievi la fedeltà del canto. Quando sentiva un chazzan (ufficiante) che faceva qualche gorgheggio, alla fine della tefillà, con un sorriso di apprezzamento per chi aveva una bella voce, gli diceva: “Hai puzzato…” espressione che in giudaico romanesco significa sei stato troppo fanatico.
Altra frase che ripeteva spesso quando sentiva un chazzan che non aveva la voce adatta per il tempio maggiore e non si sentiva fino alle ultime file, era: “La tevà è de marmo e ce vò o petto d’acciaio!”
Nella sua lunga vita comunitaria ha ricoperto anche l’incarico di direttore delle scuole ebraiche e i suoi fratelli e sorelle più piccole lo fecero penare non poco.
Intraprese poi una sua attività professionale come agente di commercio, ma continuò fino a che la salute glielo ha consentito, ad essere in tevà tutti gli shabbatoth e i moadim col suo manto e cappello (ora conservati ed esposti in Israele al Beth Hatefuzoth, il museo delle diaspore) prestando il suo servizio come volontario senza percepire compensi.
Diceva che il suo sogno era quello di morire in tevà!
Era un maestro molto severo, pretendeva dai suoi allievi chazzanim una dizione perfetta.
Ci urlava spesso: “Bisogna scandire bene le parole!!!… Le finali…. Non si sentono le finali delle parole!”
Chi come me ha avuto l’onore di studiare con lui, oggi gli è particolarmente grato per questa sua pignoleria, ma soprattutto per averci tramandato gli antichi e unici canti liturgici romani e a farci comprendere la differenza tra una cantata e una tefillà (preghiera) di cui bisogna comprenderne il significato e mettere tutto il sentimento possibile, affinché le nostre preghiere vengano ascoltate.
Iehì zichrò baruch